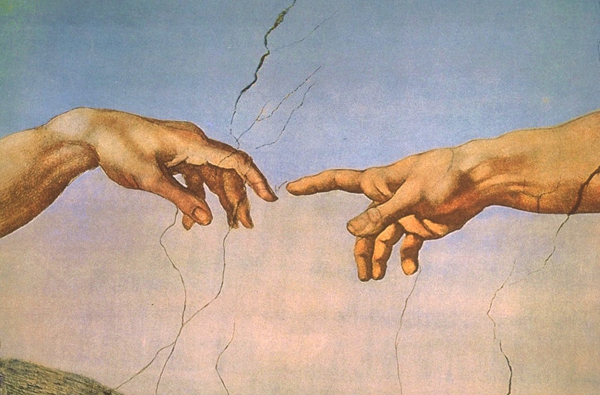E’ da settant’anni che in Italia le parti sociali si appassionano ad un gioco che non ha equivalenti nel panorama internazionale. Il gioco consiste nel restare fuori della costituzione senza, per ciò stesso, mettersi contro, obbligando i giocatori a cercare altrove ciò che vi sta dentro.
Confesso di avere avuto la tentazione di radunare queste pagine sotto il medesimo titolo di un film del 1977 di Steven Spielberg che piacque a tutti, grandi e piccini: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Poi ho desistito. In primo luogo, nel linguaggio della fantascienza, può denominarsi del terzo tipo l’incontro tra terrestri e alieni che ne determina il contatto fisico, ossia il più ravvicinato possibile: nel nostro caso, invece, il contatto è stato il più indiretto possibile. In secondo luogo, la pellicola spielberghiana è un discorso sull’amicizia, mentre una disincantata ricostruzione del rapporto tra i sindacati e l’insieme delle quattro norme della costituzione che li riguardano – gli artt. 39-40-46-99 – ne scoperchia l’ambiguità.
Lo spettacolo è talmente familiare al pubblico di casa da non impressionarlo più. Tuttavia, mi sono venuto persuadendo che all’assuefazione ha contribuito anche la decisione della storiografia giuridico-sindacale di prendersi una vacanza. Considerando che questo capolavoro di acrobazia è una conseguenza di costrizioni imposte dalla storia – valutazione in sé corretta – si è auto-esonerata dall’esaminarlo criticamente. Il che è soltanto un arbitrio. Perciò, anche se molti degli effetti del prolungato dominio dell’informale sono irreversibili ed è insensato polemizzare con ciò che doveva succedere, non sarà mai troppo tardi porsi una serie di interrogativi. Più sugli effetti di una persistente a-legalità costituzionale che sulle sue ragioni, più sulla natura dei costi degli espedienti messi in atto che sulla loro efficacia, più sulla preterintenzionalità degli esiti raggiunti che sulla lucida determinazione di raggiungerli.
Si deve per l’appunto alla circostanza che finora nessuno si è rivolto domande del genere se ha del clamoroso il fraintendimento del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 2014 che costituisce l’evento normativo più significativo, anche se tuttora incompleto, prodotto dall’autonomia negoziale collettiva negli ultimi vent’anni. Infatti, solamente l’insufficienza della griglia di lettura usata dalla generalità degli osservatori può giustificare che abbiano trascurato l’eccezionalità del contesto di riferimento, dando per scontata l’ininfluenza del perché e come esso si è venuto costruendo col trascorrere del tempo. Eppure, il suo carattere emergenziale è facilmente riassumibile in una proposizione del seguente tenore: il sistema era giunto sull’orlo dell’implosione a causa dell’insostenibilità dell’anomalia del suo impianto originario. E ciò perché, come apparirà chiaro al termine del discorso, gli effetti dello sgretolarsi del solo argine di contenimento e controllo del suo processo di de-costituzionalizzazione si erano sommati a quelli connessi all’eterogenesi dei fini subita dalla norma-simbolo della legislazione di sostegno, l’art. 19 st. lav., dopo la riformulazione che nel 1995 ne aveva dettato il legislatore popolare. Il virus della contrattazione “separata”, anche a livello nazionale, stava minacciando la tenuta del sistema contrattuale e, nella Fiat di Sergio Marchionne, l’art. 19 era degenerato in un meccanismo di estromissione dall’area legalmente protetta di un sindacato, la Fiom, di cui nessuno può contestare né l’effettività né l’ampiezza della sua capacità rappresentativa, ma che non aveva sottoscritto l’accordo aziendale. Tant’è che nel 2013 l’Alta Corte si pronuncerà nel senso che, come la sottoscrizione meramente formale del contratto aziendale non basta a fondare la titolarità dei diritti sindacali, così la mancata firma non può produrne la perdita; diversamente, si legittimerebbe “una forma impropria di sanzione del dissenso che incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato” e, al tempo stesso, sulla libertà dei lavoratori di scegliere la rappresentanza che vorrebbero.
L’incostituzionalità della legge non scritta del doppio binario
Sia per valutare la potenzialità distruttiva del cortocircuito che per accertarne le responsabilità è indispensabile ricordare gli inizi, partendo da un dato incontrovertibile: con la cooperazione (ma si potrebbe anche dire: complicità) delle centrali sindacali, immediatamente dopo l’entrata in vigore della costituzione lo Stato scelse in materia sindacale e del lavoro una linea di politica del diritto morbida, flessibile, praticabile senza provocare chiassosi contrasti frontali. Ai miei studenti ne parlavo come della legge non scritta del doppio binario: non-ingerenza e non-indifferenza. E’ la legge che ha trovato applicazione per tutto il tempo occorrente per bonificare il terreno nel quale era germogliata la normativa fascista.
Viceversa, convinti che fosse nell’interesse di una Repubblica “fondata sul lavoro” tracciare in anticipo l’itinerario del rapporto tra sindacato e costituzione, i padri costituenti lo avevano presidiato da una quantità di interventi legislativi.
Non basta dire che, crollato il fascismo, il sindacato era tornato ad essere un soggetto senza uno statuto giuridico che lo distinguesse dagli altri corpi intermedi e il contratto collettivo era riprecipitato nella condizione in cui lo trovò il fascismo e da cui il fascismo lo aveva tirato fuori con una risolutezza ammirata dappertutto: nelle aule giudiziarie, nelle Facoltà di Giurisprudenza delle Università del Regno, nelle piazze; anche all’estero. Occorre tenere conto della dirompente grandiosità dei propositi dichiarati dalle maggiori forze politiche rappresentate nell’Assemblea costituente: esse volevano disegnare un quadro politico-istituzionale in grado di valorizzare il lavoro in misura esponenziale. Per questo, lo spaesamento dei padri costituenti non poteva essere meno grande dell’entusiasmo che li animava: l’obiettivo era senza precedenti nella storia dell’Italia unita.
Ciononostante, guardando il mosaico costituzionale che indica le tappe del cammino raccomandato, è dato riconoscervi la sintesi di una progettazione come potevano averla elaborata gli uomini migliori dell’Assemblea costituente negli anni della dittatura trascorsi in esilio o al confino, da prigionieri politici o da stranieri in patria.
Propensi a presumere che esistesse una certa separatezza tra la sfera della politica e la sfera del sociale, condividevano l’idea che il sindacato si distingue dal partito, se non mantenendosi il più distante possibile dalla prima, facendo della seconda il suo terreno d’elezione. Davano per scontato che si sarebbe svenato pur di vedersi concessa dallo Stato la legittimazione a stipulare contratti collettivi efficaci erga omnes – ossia, ad esercitare un potere sostanzialmente para-legislativo – e vedevano in lui anche un portatore di competenze specifiche che ne giustificherebbero la cooptazione nell’attico dell’edificio istituzionale. Se lo immaginavano conflittuale, ma non antagonistico, e quindi disposto ad entrare nelle “stanze dei bottoni” assumendosi la sua quota di responsabilità.
La conferma che questo fosse il loro retro-terra culturale è ricavabile in maniera pressoché testuale dal documento costituzionale, là dove mette a disposizione del sindacato la medesima cassetta degli attrezzi rinvenibili nell’agenda politica del riformismo dell’età giolittiana. L’affinità senz’altro più marcata è ravvisabile tra il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e la camera di rappresentanza degli interessi economico-professionali che una legge del 1902 denominava Consiglio superiore del lavoro e Filippo Turati, non senza euforia perché non c’era ancora il suffragio universale, ridefiniva “Parlamentino del lavoro”. Anzi, l’attrazione esercitata da questa esperienza deve essere stata molto forte. Tant’è che il primo passo compiuto per attuare il progetto costituzionale è stato quello di istituzionalizzare un sindacato ancora sospeso fra un passato che non passava e l’indeterminatezza di un futuro che tardava ad arrivare. Infatti, nel 1957 è istituito il Cnel composto da rappresentanti delle categorie produttive ed esperti con compiti di alta consulenza del Parlamento e del Governo in materia di legislazione economica e sociale. Un ente che, sessant’anni dopo, rischierà di essere abolito, malgrado il tentativo di rilanciarlo effettuato da una legge di riforma del 1986. Entrato nel mirino degli autori di una complessa revisione costituzionale che si proponeva inter alia di “ridurre i costi della politica”, gli avevano appiccicato addosso la vergognosa etichetta del più inutile degli enti inutili. Respingendo la riforma costituzionale, l’esito del referendum del 4 dicembre 2016 lo ha mantenuto in vita; ma non si può fare a meno di rilevare che nessuna voce autorevole si era levata in sua difesa durante l’infuocata campagna referendaria. In effetti, soltanto un’esigua minoranza degli elettori sapeva che il Cnel, vittima di una inarrestabile atrofia progressiva in un clima di assoluta indifferenza, di fatto era già deceduto. Come dire: nato su presupposti che si sono rivelati inesatti, soltanto per caso è scampato al trauma di un decesso oltraggioso e, quanto alle prospettive che il legislatore popolare gli ha inopinatamente riaperto, per ora si sa soltanto che, per lui, è un’avventura più morire che vivere.
Dopo questa esperienza, non si può più raccontare che il destino più umiliante che possa toccare ad una norma, specialmente se la norma fa parte di un testo costituzionale, è quello di scivolare nel malinconico limbo dell’irrilevanza. La sorte toccata all’art. 99 fa capire che c’è di peggio. Per questo, non si fa involontaria ironia dicendo che l’art. 46 ha avuto almeno la fortuna di non essere screditato: è stato semplicemente ignorato. Come, del resto, probabilmente volevano i suoi stessi autori, che ne concordarono una formulazione, se non proprio liliale, distante dalla contemporaneità. Non vi risuona infatti neanche una pallida eco delle violente tensioni politico-ideologiche che attraversavano l’esperienza ancora in atto dei consigli di gestione nati nel dopoguerra che i più erano interessati a consegnare alla memoria storica come fattori più di disordine che di “armonia con le esigenze della produzione” cui si richiama espressamente l’incipit della disposizione. Perciò, non è casuale che l’art. 46 abbia ricevuto attuazione soltanto in isolati episodi locali di breve durata, incapaci da soli di creare le premesse per edificare la “democrazia industriale” di cui non si è mai smesso di favoleggiare. Per certo, la legge per stabilire “modi e limiti” del diritto dei lavoratori a “collaborare alla gestione delle aziende (…) ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro” non c’è; un po’ perché è inesistente la disponibilità degli imprenditori ad attribuire alla “collaborazione” un significato meno paternalistico di quello che il medesimo termine assume nell’art. 2094 del codice civile che disegna l’identikit dell’ideal-tipo di lavoratore dipendente e un po’ perché la sola forma partecipativa gradita (e frequentata) dal sindacato del dopo-costituzione consiste in procedimenti di informazione preventiva relativamente a decisioni della direzione aziendale che producono effetti soprattutto sul livello occupazionale.
Ad ogni modo, ciò che lascia maggiormente interdetti è non tanto che l’attuazione del progetto costituzionale attinente al ruolo del sindacato nella Repubblica “fondata sul lavoro” abbia avuto inizio con l’art. 99 quanto piuttosto che si sia conclusa con l’art. 99. Infatti, gli artt. 39-40, che corrispondono alle tessere di gran lunga più importanti del mosaico costituzionale, hanno avuto un impatto differente da quello che si aspettavano i costituenti ed è plausibile congetturare che lo scostamento rispetto alle previsioni non li abbia gratificati.
I destini incrociati degli articoli 39 e 40
Se ciò che è capitato all’art. 39 induce gli interpreti ad affermare (come piacerebbe al fondatore del teatro dell’assurdo) che è “inattuato, inattuabile e tuttavia attuale”, l’art. 40 non poteva non parlare sinistramente ad un personale politico e ad un ceto professionale abituati ad una normativa che criminalizzava il medesimo comportamento collettivo cui l’Assemblea costituente doveva la sua stessa esistenza: “senza gli scioperi del ’43 nelle fabbriche del Nord”, si dicevano i suoi membri, “non saremmo qui, perché tutto è iniziato da lì”.
E’ verosimile che Giuseppe Di Vittorio segretario generale della Cgil giudicasse soddisfacente il contributo dato da Giuseppe Di Vittorio deputato della Costituente, il più ascoltato sui temi sindacali dell’intera Assemblea. Alla fin dei conti, se col carisma che poteva avere soltanto il leader della più grande formazione sindacale del dopo-Liberazione aveva portato la sinistra a superare le resistenze ad approvare una norma solo in apparenza semplice e piana come quella adottata in materia di sciopero dalla costituzione francese, Giuseppe Di Vittorio era il padre putativo dell’art. 39 e proprio per questo mai e poi mai avrebbe ammesso che la creatura non va oltre un annuncio del tipo “armiamoci e partite”. Infatti, anche in presenza di condizioni perfettamente normali, la ricerca di un equilibrio compatibile coi principi fondativi dei regimi democratici tra la dimensione privato-sociale e la dimensione pubblico-statuale tanto del sindacato quanto della contrattazione collettiva presenta le stesse difficoltà di un’equazione a più incognite. La soluzione che ne propone Di Vittorio è quella che poteva venire in mente ad un facilitatore che è pronto a scommettere che un sindacato degno di questo nome non accetterebbe di confondersi con una qualsiasi associazione di fatto, perché si porta dentro un plus o un aliud che ne fa un soggetto sui generis. E’ sui generis perché si considera a rischio di piombare nell’angoscia esistenziale che procurano le crisi d’identità, qualora lo Stato non lo metta nella condizione di stipulare contratti collettivi valevoli ultra partes, ed è questa la differentia specifica che lo costringe ad aspirare alla personalità giuridica, comunemente (ma anche miticamente) intesa come garanzia di credibilità agli occhi, se non dei lavoratori, dello Stato. Ne deriva che, al di là delle intenzioni, gli artt. 39-40 formano una coppia di inseparabili i cui destini sono incrociati. Infatti, tra una norma come l’art. 39 che apre una generosa linea di credito a favore del sindacato e una norma come l’art. 40 dal quale trapela una insuperata riluttanza a considerare il conflitto un valore in sé positivo sussiste un legame sotterraneo. Sta lì a documentarne l’esistenza il più organico disegno di legge presentato (nel 1951) da un governo col proposito di attuare entrambe le norme. Lo sciopero, vi si legge, può essere proclamato solo da sindacati riconosciuti dallo Stato, solo a contratto collettivo scaduto e solo per modificarne le clausole. Come dire: l’art. 39 non si attua disgiuntamente da leggi limitative del diritto di sciopero ovvero si attua simultaneamente all’art. 40.
Benché il disegno di legge sollevasse obiezioni di varia natura, non può dirsi che il Parlamento non lo abbia approvato perché temeva che sarebbe stato travolto da una valanga di censure d’incostituzionalità; all’epoca, semmai, prevaleva l’opinione che le due norme costituzionali sono strettamente collegate e, comunque, la Consulta non era ancora operante. Ad ogni modo, non venne neanche discusso in sede parlamentare per volontà dello stesso esecutivo che giudicò prioritaria l’esigenza di migliorare la governabilità del paese con una legge elettorale che correggesse in senso maggioritario il sistema proporzionale.
Il pluralismo sindacale in salsa italiana
La scelta è facilmente comprensibile: l’anti-fascismo che era stato il collante della Resistenza e il motore della fase costituente aveva perduto la sua centralità sia nel pensiero che presiede all’azione politica sia nel sentimento popolare dominante nel dopo-Liberazione e l’anti-comunismo era diventato il nuovo collante. Diversamente, la Cgil unitaria non si sarebbe sfasciata con modalità tanto traumatizzanti. La verità è che la rottura del Patto di Roma che l’aveva fatta nascere è necessaria per poter completare, sul versante della rappresentanza sociale del lavoro, la conventio ad excludendum stipulata tra i partiti che reggono i governi centristi a conduzione democratico-cristiana nel clima della guerra fredda che spaccherà in due il mondo per numerosi decenni.
E’ da quel momento che la tentazione di cancellare di fatto tre quarti del mosaico di norme in cui si riflette la cultura giuridico-sindacale dei costituenti diventerà irresistibile. Da allora ha inizio la stagione del “meno si legifera in materia sindacale e del lavoro, meglio è” e la crescente trasversalità del successo di uno slogan del genere dà la misura dell’estensione raggiunta dal pregiudizio anti-istituzionale di cui si è alimentato il pluralismo sindacale di casa nostra. E’ la stagione dell’ibridazione della rappresentanza sociale del lavoro in bilico tra pubblico e privato; del bricolage contrattuale protetto da giudici, toghe d’ermellino incluse, secondo i quali pezzi significativi del diritto corporativo sarebbero in grado di sopravvivere al cambio di regime; dell’estemporaneità creativa ed insieme del conservatorismo per convenienza. E’, insomma, la stagione degli ossimori che dura tuttora ed è incontestabile che si è voluto aprirla per blindare un sistema politico in cui l’alternanza governo-opposizione era proibita.
Con ciò intendo dire che, se il diritto sindacale e del lavoro del dopo-costituzione assumerà l’aspetto di un legno storto, lo si deve al fatto che i partiti si considerano moderni principi e i sindacati fidati scudieri dei medesimi. In realtà, la Cgil fa di tutto per presentarsi all’opinione pubblica come il sindacato per il quale un buon risultato elettorale dei partiti di sinistra (il più grosso dei quali, il PCI, vuole che la Cgil funzioni da cinghia di trasmissione della sua strategia politica di conquista del potere) è meglio di un buon contratto. Analogamente, l’establishment politico e confindustriale vede nella Cisl l’avamposto piazzato in partibus infedelium su cui fare assegnamento per dare al mondo delle imprese un partner più collaborativo che conflittuale e fronteggiare un’egemonia culturale del sociale avversa alle politiche governative (non solo) del lavoro. Per favore, a questo punto, non chiedetemi della struttura sindacale d’ispirazione laica che si chiama Uil. Non lo so né lo saprò mai. Per me, non è che un grande equivoco mai chiarito. Sta di fatto che quel poco che può chiedere a se stessa e agli altri è anche il massimo cui può aspirare. Chiede di essere ammessa al dialogo con le altre confederazioni su di un piede di parità e di consolidarsi, come in effetti le riuscirà perché ha sempre avuto l’abilità di massimizzare i benefici connessi all’ambiguità di ruolo che solitamente contraddistingue le terze forze o i ricercatori di terze vie.
Come dire che il pluralismo sindacale in salsa italiana è inautentico nell’ampia misura in cui nasce nel segno della subalternità a logiche e dinamiche legate all’evoluzione di un quadro politico spadroneggiato dai partiti di massa; logiche e dinamiche che si sovrappongono a quelle sindacali, anche se allora non se ne poteva avere una nozione precisa.
Tuttavia, è innegabile che la Cisl abbia speso i suoi primi anni di vita per acquistare una propria identità. Che, ovviamente, non potrà trovare se non in contrapposizione con la Cgil e con quell’art. 39 in cui la Cgil si riconosce pienamente. Suo infatti è l’aprioristico rifiuto di vedersi riconosciuta dallo Stato la vocazione a rappresentare indistinte collettività: un tradimento agli occhi della Cgil e una provocazione agli occhi dei costituenti. Sua è l’intransigenza con cui difende la libertà sindacale contro le interferenze del potere pubblico che vede minacciate persino dal test di democraticità condotto sugli statuti sindacali da qualche funzionario pubblico più o meno occhiuto che l’art. 39 impone in vista delle “registrazione” del sindacato nell’istituendo albo degli enti d’interesse collettivo giuridicamente riconosciuti dallo Stato, ossia legittimati ad attivare una fonte di auto-regolazione che rompe il monopolio statale della produzione normativa. Sua è la narrazione secondo la quale il mosaico costituzionale, con tutto il protagonismo legislativo che sollecita, riecheggia la legificazione cingolata con la quale il fascismo asfaltò l’universo dei rapporti Stato-sindacati-lavoratori-imprese. In effetti, come quello del ventennio, il sindacato immaginato dai padri costituenti ha impressa nel suo codice genetico la bipolarità che ne fa un soggetto che ha l’incarico di rappresentare gli iscritti in base agli ordinari meccanismi previsti dal diritto civile e, tuttavia, ha la vocazione a sostituirsi al legislatore per assicurare alla generalità dei lavoratori appartenenti alle varie categorie trattamenti tendenzialmente uniformi. In conseguenza, anche il contratto collettivo privilegiato dall’art. 39, ossia il contratto nazionale di categoria, ha natura duale. Come nel 1927 osservava Francesco Carnelutti a proposito del contratto collettivo stipulato dai sindacati defunti, ha l’aspetto esteriore del contratto e l’anima della legge. Pertanto, l’enfasi con cui la Cisl rivendicava l’incompatibilità della libertà di cui gode il sindacato con l’integrazione del medesimo nell’ordinamento dello Stato metteva a disagio il Di Vittorio segretario generale della Cgil che conveniva col Di Vittorio deputato della Costituente sulla necessità che il sindacato pagasse un prezzo, sia pure il più piccolo possibile, per farsi attribuire dallo Stato la facoltà di codeterminare su base consensuale le condizioni di lavoro e di vita di moltitudini di cittadini che non lo hanno scelto come proprio rappresentante. Per la Cisl, invece, la norma-cardine del codice civile che non senza retorica formula il principio generale secondo cui il contratto ha sì “forza di legge”, ma limitatamente alle parti che lo hanno stipulato, è un dogma intoccabile e non c’è motivo per violarlo nel campo della contrattazione collettiva.
Centralità del principio del mutuo riconoscimento nella costituzione materiale delle relazioni industriali
Resta da chiarire quale fosse la ragione di fondo per cui la predilezione della Cisl per un modello di contrattazione collettiva alternativo non le impedisse di aderire alla vulgata secondo la quale il contratto collettivo nazionale del dopo-costituzione, il solo operante fino agli anni ’60 inoltrati, è un succedaneo del contratto collettivo del’epoca corporativa. In realtà, il modello preferito è alternativo a quello progettato dai padri costituenti nel senso che il sistema contrattuale organizzato dagli attori sociali coi mezzi di cui dispongono si regge sul principio del mutuo riconoscimento in base al quale i partner sono liberi di scegliersi reciprocamente: come l’imprenditore tratta con chi gli pare, così ogni sindacato si allea con quello che gli conviene e, se può, sgambetta quello che gli dà fastidio. Un principio del genere, che presuppone una condizione di libertà d’azione sconfinante nella discrezionalità, ha il pregio di mettere in difficoltà un soggetto che, come la Cgil, è costretto a muoversi in un ambiente in cui l’ostilità nei suoi confronti è accresciuta dai rapporti organici che intrattiene coi partiti della sinistra (come si diceva allora) marxista. Ma esula, e anzi è espulso ab origine, dal modello di contrattazione collettiva ex art. 39. Il quale punta sull’unicità dei negoziati e del negoziatore in nome e per conto delle categorie, affidando la soluzione dei conflitti endo-sindacali che si manifestassero durante le trattative alle maggioranze possibili all’interno di un organismo – la “rappresentanza sindacale unitaria” – dove il potere contrattuale collettivo dei sindacati si ripartisce in proporzione alla consistenza associativa dei medesimi. Infatti, la composizione della delegazione sindacale trattante è vincolata: necessariamente unitaria, prende le sue decisioni sulla base di regole sovra-ordinate che ne fanno un “mini-parlamento” dove i sindacati contano in proporzione al quantum accertato della propria capacità rappresentativa. Pertanto, l’attuazione dell’art. 39 sottrarrebbe di colpo dal caveau della privatizzazione delle regole del gioco la vera riserva aurea della medesima, perché la legittimazione a contrattare del sindacato dipenderebbe non più dalla volontà degli altri agenti contrattuali, a cominciare dalla controparte, ma soltanto dal perfezionarsi dell’iter della “registrazione” e la forza contrattuale del sindacato “registrato” si misura in rapporto al numero degli iscritti. Come dire che il principio del mutuo riconoscimento è potenzialmente capace di produrre effetti penalizzanti paragonabili a quelli prodotti sul versante governativo dalla conventio ad excludendum. Si dirà che mai la Cgil si è vista negare l’accesso ai tavoli contrattuali più importanti. Ciò non toglie che non poteva trascurare le rovinose conseguenze di un diniego, in astratto possibile e legittimo. Sapeva che, se non è ammesso al tavolo contrattuale, un sindacato deperisce e che la sua capacità di mobilitazione non è illimitata. Sapeva che il funzionamento del principio del mutuo riconoscimento è basato sul consenso e che le cose si erano messe in modo che, mentre lei doveva guadagnarselo, Cisl e Uil ce l’avevano in tasca a priori. Per questo, l’effetto potenzialmente escludente del principio-base di quello che sarà chiamato l’ordinamento intersindacale ha esercitato sulla Cgil una pressione indiretta, ma decisiva. L’ha orientata a “normalizzarsi” e, in primo luogo, a trattare gli altri sindacati come carissimi nemici, ciascuno dei quali troverà così più d’un’occasione per liberarsi dal complesso della “grande Cgil”. Non di rado, anzi, soltanto un comprensibile calcolo di convenienza tratterrà Cisl e Uil dal manifestare apertamente la medesima soddisfazione che prova il padre al rientro del figliol prodigo restio a confessargli i danni che ha causato alle stesse idee di progresso per seguire le quali se ne era andato di casa. Conta soltanto l’essere tornati insieme perché si è capito che ciò che unisce supera ciò che divide.
D’altra parte, far cadere l’accento su ciò che unisce per sdrammatizzare la lacerazione che si era consumata consentiva l’inclusione delle centrali sindacali in quello che ho sempre chiamato il club delle confederazioni sindacali più rappresentative: per ciascuna di esse era l’unica maniera di stare fuori della costituzione riducendo al minimo storicamente consentito il rischio di andarle contro. Un esito, quest’ultimo, che nessuno voleva. La Cisl, infatti, pur essendo la paladina della privatizzazione integrale dell’intero fenomeno sindacale senza regole precostituite dall’alto né presidi legali, non era per niente scandalizzata dalle somiglianze che in pratica si stabilivano tra il contratto collettivo chiamato di diritto comune – chissà perché, dato che per quest’ultimo era un’entità sconosciuta – e il detestato contratto collettivo ex art. 39.
La verità è che tutti – governi, sindacati e lavoratori – avevano buoni motivi di compiacersi per la capacità argomentativa che giurisprudenza dava prova di possedere affrontando problemi tecnico-giuridici che solo una legge di attuazione dell’art. 39 potrebbe risolvere: dal problema dell’inderogabilità del contratto collettivo a quello della sua efficacia generale (almeno limitatamente alle tariffe salariali). Nel complesso, infatti, la giurisprudenza giunge ad un risultato approssimativamente simile a quello ottenibile attraverso il riciclaggio degli automatismi previsti dal diritto corporativo e dunque riproduce nei limiti del possibile l’esperienza giuridica che i giudici hanno imparato a conoscere studiando all’Università. Però, frequenza ed ampiezza dell’uso che se ne faceva dimostrano che il sindacato del dopo-costituzione ha evitato l’inondazione legislativa “minacciata” dai padri costituenti optando per la devoluzione al potere giudiziario di un compito che attiene alla sua mission ego-altruistica ed invece gli appare paradossalmente ultra vires. E’ il compito di tutelare il lavoratore con riguardo meno alla sua (eventuale) veste di associato che a quella (pressoché certa) di utente del servizio di più largo consumo che ci si aspetta dal sindacato. Per questo, mi sembra intellettualmente onesto riconoscere che la giurisprudenza ha garantito che non uscisse dal senso comune l’equiparabilità del contratto collettivo di categoria a un grande serbatoio idrico bisognoso dell’impianto capace di trasformare l’energia potenziale dell’invaso in energia cinetica: dopotutto, il totale dei sindacalizzati è rimasto costantemente al di sotto di un terzo della popolazione attiva. Ed è stata la giurisprudenza a farsi carico d’insegnare ad una dottrina legata alla tradizione pandettistica come sia possibile, in un sistema di civil law, servirsi dell’empirismo del common law che permette di adottare gli stratagemmi idonei a far arrivare la corrente elettrica in tutte le abitazioni, anche le più periferiche. Come dire che senza il contributo della giurisprudenza l’art. 39 non avrebbe potuto trasmettere la luce di una stella morta: la vedi ancora, ma la sua fonte si è spenta.
La circostanza che una compatta giurisprudenza si sia consapevolmente sostituita al legislatore per arrivare a soluzioni provviste di un elevato tasso di desiderabilità sociale non significa, tuttavia, che sindacati e lavoratori siano tenuti a manifestarle un’incondizionata gratitudine. Anzi, se sindacati e lavoratori si auguravano che la performance giurisprudenziale fosse replicata in materia di sciopero, ci saranno rimasti malissimo. Non che la supplenza giudiziaria non ci sia stata. Tutt’al contrario, tenuto conto che l’astensionismo legislativo riguardante lo sciopero è stato interrotto soltanto nel 1990 e limitatamente peraltro all’area dei servizi pubblici essenziali, supplenza c’è stata ed ha raggiunto un’estensione mai vista in un sistema giuridico di civil law. Il fatto è che ha avuto un segno differente da quello della giurisprudenza in tema di contrattazione collettiva: più avaro che prodigo, più diffidente che fiducioso, più di chiusura che d’apertura. Ut erat in votis, sia pure in mancanza di meglio, dei pubblici poteri. Ai quali non poteva sfuggire che l’educazione giuridica ricevuta dai giudici li avrebbe portati per lungo tempo a valutare ogni forma di sciopero in un’ottica prefettizia e dunque sembrava ragionevole prevedere che avrebbero agito come severi custodi della pace sociale. Non sbagliarono i calcoli. Infatti, l’attuazione parziale dell’art. 39 ascrivibile alla creatività interpretativa della giurisprudenza si è intrecciata con la coeva attuazione giurisprudenziale dell’art. 40 sia attraverso l’utilizzo delle norme repressive del conflitto sociale contenute nel codice penale degli anni ’30 – lo smantellamento della normativa fascista ad opera della Corte costituzionale è stato graduale ed è terminato intorno alla metà degli anni ’70 – sia sfruttando le risorse del diritto dei contratti che permetteva di costruire la figura dello sciopero anomalo o ingiusto o sleale per deprivarlo della protezione garantita dalla costituzione. Edmondo Berselli direbbe che la manipolazione interpretativa dell’art. 40 è “il più mancino dei tiri” che la magistratura potesse permettersi ai danni di sindacati e lavoratori. E ciò quantunque la metamorfosi giuridica dello sciopero fosse stata radicale: era un delitto e i costituenti lo avevano trasformato in un diritto fondamentale; inoltre, ritenendo che la secolare repressione poliziesca dello sciopero meritasse una riparazione adeguata, derogarono anche al principio della parità delle parti sociali nell’uso dei mezzi della lotta sindacale. Per loro, infatti, la serrata era un disvalore. Ancorché depenalizzata, costituisce tuttora un illecito contrattuale equiparabile alla mora credendi e dunque non esonera di per sé dall’obbligo retributivo.
Come ho appena finito di raccontare, la voragine legislativa che si è protratta per decenni, e in larga misura persiste tuttora, è stata colmata dal ceto professionale degli operatori giuridici i quali, superate le forti resistenze iniziali, si sono un poco alla volta sbilanciati a favore di un’interpretazione dell’art. 40 sempre meno restrittiva nei confronti dell’autotutela collettivo-sindacale. Il che porta a concludere che il laconico disposto costituzionale è stato all’altezza delle aspettative della sinistra costituente che lo votò: paradossalmente, ha potuto esserlo proprio a causa della sua mancata attuazione ad opera di un legislatore che, se avesse potuto, avrebbe voluto fermare le lancette dell’orologio. Soltanto dopo molto tempo, e soprattutto nel mutato clima che accompagnerà l’emanazione dello statuto dei lavoratori, il legislatore si deciderà a comunicare alla magistratura che sarebbe stato opportuno ripensare l’atteggiamento mentale e rivedere il consueto apparato concettuale. Infatti, se l’art. 28 st. lav. fornisce i mezzi necessari per attivare la repressione giudiziaria di ogni comportamento dell’imprenditore diretto a impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero, ciò vuol dire che quest’ultimo, prima ancora d’essere oggetto di una regolamentazione legale, deve essere protetto. Il conflitto – parola di ministro: il ministro democratico-cristiano Carlo Donat Cattin che condusse in porto l’operazione-statuto felicemente avviata dal suo predecessore, il socialista Giacomo Brodolini – non è necessariamente un’anomalia, bensì un dato fisiologico di un moderno sistema di relazioni industriali.
A mio avviso, tutto quel che si può dire del sistema sindacale di fatto fin qui sommariamente descritto lo ha già detto l’Innominabile: “grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente”. Senz’altro in attivo, comunque, è il bilancio culturale che ancora oggi la Cisl è in grado di redigere. Sua è l’intuizione politica che l’inattuazione di un progetto costituzionale, diventato nel giro di pochi mesi non memo ambizioso della quadratura del cerchio, va reclamata in nome e nell’interesse della stessa democrazia; e ciò perché un movimento sindacale con enormi ritardi da colmare quanto ad esperienza di libertà ed autonomia meritava la chance di farsi la sua al di fuori di schemi regolativi prefabbricati altrove e calati dall’alto, scommettendo sulla sua voglia di imparare a camminare senza stampelle legali. Anche se, muovendo da premesse del genere, può succedere che suoi esponenti di spicco finiscano per posizionarsi in chiave anti-legalitaria: come comprova la decisione di deputati dirigenti della Cisl di uscire dall’aula per non votare, nel 1966, il provvedimento legislativo che revocò la licenza di licenziare. Con questa protesta, intendevano per l’appunto denunciare un’indebita irruzione del legislatore in territori riservati all’azione sindacale.
Stando così le cose, è evidente che cresceva a vista d’occhio il bisogno di razionalizzare dal punto di vista teorico le inadempienze costituzionali e, argomentando che non erano un male in sé, ricomporle in sistema, per incerottato che fosse.
Presagendo che un’organica legge sindacale sarebbe arrivata chissà quando, è toccato a Gino Giugni dimostrare che l’adesione acritica all’ottocentesca concezione stato-centrica del diritto penalizza la vitalità dell’autonomia privato-collettiva nella misura in cui ne nega arbitrariamente l’attitudine a creare un ordinamento iure proprio. In effetti, il sindacato degli anni ’50 si stava muovendo sul terreno più adatto a riattualizzare la teorizzazione compiuta da uno dei maggiori giuristi del Novecento dell’esistenza di ordinamenti ai margini di quello statuale, giustapposti e paralleli al medesimo, se non proprio alternativi. Riflettendo sulla crisi dello Stato e del suo assolutismo, all’aprirsi del secolo scorso Santi Romano era giunto a scoprire che l’antica massima ubi societas ibi ius non significa soltanto che la società non può fare a meno di regole: significa anche che la società produce regole; regole di natura extra-legislativa. Come dire che il dinamismo spontaneo dei gruppi privati è in grado di costruire una legalità non meno vincolante, e anzi talora più efficiente, di quella statuale. Per questo, anziché attardarsi con tono lamentoso-accusatorio nel rammarico per le speranze suscitate dall’art. 39 e andate deluse, Giugni valorizzò la felix culpa di governi, Parlamenti e sindacati recalcitranti ad attuare l’art. 39, proponendone una chiave di lettura giustificazionista ed insieme ottativa, destinata ad avere uno straordinario successo perché esprimeva un’idea che aspettava soltanto qualcuno che se ne assumesse la paternità.
Patriottismi d’organizzazione vs. unità sindacale
Gino Giugni, però, non sarebbe diventato il giurista più stimato dai maggiori sindacati e l’opinions leader di intere generazioni di operatori giuridici se la scissione della Cgil non avesse ostacolato l’unità d’azione sindacale meno, molto meno di quanto temevano o auspicavano in molti. Certo, aveva impedito l’attuazione dell’art. 39 per le note ragioni extra-sindacali, ma non si era tradotta in una condizione preclusiva del consolidarsi di regole del gioco condivise e passabilmente democratiche che finivano per giovare a tutti. In effetti, tranne che negli anni ’50 durante i quali i sindacati dovevano accentuare le proprie identità oppositive per garantirsi visibilità e riconoscibilità, è un’insopprimibile comunione d’interessi che li trascina ad agire unitariamente. Dovendo contrattare con la medesima controparte, soltanto l’unità d’azione permette il formarsi di un rapporto di forza meno asimmetrico di quello raggiungibile separatamente e dunque più vantaggioso, anzitutto, per i lavoratori. Anche per questo, durante il convegno organizzato dalla Cgil nella scuola di Ariccia per festeggiare il suo 30° compleanno Giugni non esita ad affacciare la tesi che la storia del sindacalismo del dopo-costituzione è, in realtà, “la storia di come sia cresciuta all’interno di un sistema pluralistico una condizione, se non anche un progetto, di unità sindacale. (…) Gli anni dal ’60 al ’70 io li vedo come gli anni in cui l’unità sindacale è nei fatti”. Giugni non inforca occhiali con lenti deformanti. Evidentemente, i discorsi identitari che si pronunciano durante i periodici riti congressuali delle confederazioni non lo persuadono del tutto, perché contrastano con l’omologante modello di comportamento organizzativo adottato nella quotidianità, e quindi gli sembrano racconti di comodo utili a incassare adesioni sentimentali e incentivare pulsioni istintive solo perché cancellano falsificazioni e sorvolano su contraddizioni. Quanto a me, come possono testimoniare i miei studenti, a lezione raccontavo che l’evoluzione del diritto sindacale era governata da una stabile coalizione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative che per un attimo, dopo l’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, sembrò addirittura in procinto di trasformarsi in una federazione unitaria. Se agli studenti ne parlavo come di un club elitario, c’era chi come Piero Boni, che è stato il n. 2 della Cgil ai tempi di Luciano Lama, ne parlava come della “quarta confederazione senza nome e senza bandiera”.
La terminologia è troppo estrosa per poter essere mutuata dalla Corte costituzionale, ma è questa l’impalpabile entità che la Consulta non esiterà a sponsorizzare come freno delle logiche aziendalistiche che spezzano la coesione delle larghe solidarietà d’interessi di cui il club si considera espressione. Infatti, riaffermerà la costituzionalità della versione (anteriore alla modifica referendaria) dell’art. 19 st. lav. contestata da più parti perché finiva per premiare il club con eccessiva generosità. Inoltre, tanto la Corte quanto Giugni sanno che l’unità d’azione aveva acquistato una valenza para-costituzionale perché gli stessi sindacati la considerano un sostituto funzionale della mancata applicazione dell’art. 39. Difatti, pur non smettendo mai di celebrare il culto del sindacato-associazione, persino la Cisl aveva smesso in fretta di trarne tutti i corollari, a cominciare dalla disapplicazione dei contratti ai non-iscritti, e si accontentava di far pagare a tutti una tariffa una tantum per il servizio reso. Cionondimeno, ricordo che nell’occasione celebrativa poc’anzi ricordata trasalii ascoltando Giugni sostenere: “vi è già oggi la possibilità – che in precedenza non c’era – di ricostruire intorno ad un filo unitario la vicenda complessa delle varie confederazioni”. Come dire: dopo l’autunno caldo, dopo lo statuto dei lavoratori e in presenza della Federazione sindacale unitaria che aveva nella Federazione dei lavoratori metalmeccanici (FLM) il suo vessillifero più convinto e tenace, Gino giudicava anacronistica la molteplicità di strutture confederali. Piuttosto, vi ravvisava il sotto-prodotto di un sistema politico fondato su pregiudiziali discriminatorie e diffidenze di cui si augurava il tramonto.
Viene spontaneo chiedersi cosa direbbe adesso. Adesso che, caduto il Muro di Berlino e scomparsi i partiti di massa che amavano atteggiarsi da Lord Protettori nei confronti di Cgil e Cisl, il pluralismo sindacale ha cambiato segno: evoca non più veri o presunti valori fondativi contrapposti, che un’interazione durata per decenni ha finito per diluire e ammorbidire, bensì patriottismi d’organizzazione che fanno di ciascun sindacato un’agenzia di erogazione di servizi (dai patronati agli enti bilaterali) a beneficio non tanto di rappresentati quanto di utenti-clienti. Adesso che, venuti meno i vincoli del collateralismo un po’ perché i partiti politici di massa che fecero la Repubblica sono scomparsi e un bel po’ perché gli altri non solo sono in profonda crisi, ma sono sempre meno diversi l’uno dall’altro, i sindacati si sono messi in proprio e agiscono primariamente per auto-conservarsi. Adesso che il lavoro ha perduto la L maiuscola sia perché è cambiato il modo prevalente di produrre e organizzare la produzione sia perché, direbbe Ulrich Beck, anche la politica ha perduto la P maiuscola. Adesso che il sindacato non è in grado di proporsi come agente del cambiamento, nemmeno se lo volesse, e preferisce ritagliarsi il ruolo di chaperon del cambiamento gestito da poteri più forti di lui. Adesso, insomma, la situazione parrebbe irreversibilmente mutata in misura tale da obbligare a liberarsi dalle scorie del passato più favoloso, ma anche più buio del sindacalismo rinato nel dopo-guerra.
Viceversa, si è assistito al rilancio del pluralismo sindacale all’insegna di un imperativo falsamente moraleggiante del tipo “meglio un contratto, qualunque contratto, che nessun contratto” che celebra l’apologia del primato dell’organizzazione e segna l’avvicinarsi della notte hegeliana ove non è più possibile distinguere un sindacato dagli altri in base alla diversità del patrimonio di valori culturali. E ciò soprattutto in presenza dell’art. 8 della legge 148 del 2011 che ha stabilizzato una misura d’urgenza varata durante il concitato ruit hora dell’ultimo governo di centro-destra guidato da Silvio Berlusconi. Infatti, la norma che autorizza la contrattazione “di prossimità” a derogare agli standard protettivi stabiliti non solo dalla contrattazione di livello superiore, ma anche dalla legislazione, non è interpretabile come l’indizio di una vigorosa esuberanza dell’autonomia negoziale collettiva. E’ piuttosto un sicuro indizio del prevalere di una concezione proprietaria dell’interesse collettivo e, in buona sostanza, dei diritti di cui si dispone mediante il contratto. Difatti, il monumentale Testo Unico sulla rappresentanza sindacale, confezionato con la massima discrezione e pause sapienti nell’arco di un triennio, tra il 2011 e il 2014, lega la sopravvivenza del pluralismo organizzativo dei sindacati che lo hanno sottoscritto alla promessa di aumentarne la capacità di ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle maestranze. Al riguardo, i giuristi parlano di dovere degli apparati d’influenzare i comportamenti collettivi, ma Antonio Gramsci parlava di “fiducia dell’imprenditore nella solvibilità del sindacato”, da intendersi come capacità di ottenere l’adesione dei rappresentati alla politica contrattuale decisa dai rappresentanti. Come dire che, per quanto sia culturalmente scolorito in seguito all’esaurirsi della sua funzione storica, il pluralismo sindacale è stato rivitalizzato per portare ordine piuttosto che dare voce alle basi sociali.
Vero è che, siglando il Testo Unico sulla rappresentanza, i sindacati hanno promesso che smetteranno di sottrarsi a verifiche riguardanti il “chi rappresenta chi” e la legittimazione a partecipare a processi di produzione di norme valevoli nei confronti di moltitudini di cittadini che non hanno conferito alcun mandato rappresentativo; però, il minimo che verrebbe da dire è: meglio tardi che mai. E’ altresì vero che nel trittico interconfederale 2011-2014 è formulato il principio secondo il quale i contratti nazionali saranno sottoscritti “previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori a maggioranza semplice”. Tuttavia, a parte l’indeterminatezza delle procedure che saranno adottate e l’incertezza del futuro della stessa contrattazione nazionale, il medesimo documento sponsorizza il decisionismo dei vertici al livello che in parte è già il cuore del sistema contrattuale: i contratti aziendali sono efficaci per tutto il personale “se approvati dalla maggioranza dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria” e, se firmati da rappresentanze sindacali aziendali, sono sottoponibili a verifica entro certi limiti ed a certe condizioni.